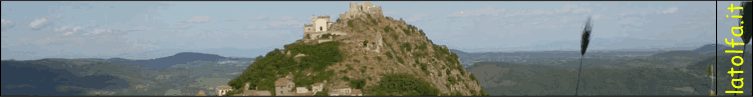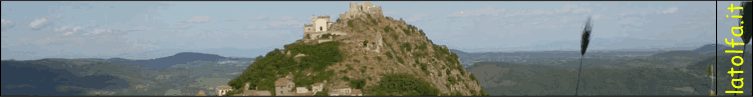II testo del decreto
prosegue concedendo l'approvazione a quella Confraternita detta del Nome di Dio che si era
già costituita.
Il padre Zobbio approva fin da allora quel cappellano che la maggioranza
dei soci vorrà eleggere.
Stabilisce che vi sia un registro che annoti i nomi e i cognomi dei
membri i quali entrando a far parte della compagnia debbono prestare
la loro opera gratis, secondo le leggi stabilite nelle costituzioni
della confraternita.
Insieme ad altre ingiunzioni si stabilisce che ogni anno venga celebrata
con solennità la festa della Circoncisione del Signore, titolare della confraternita e che venga fatta dipingere una
immagine con il padre fondatore S. Domenico che adora il nome del Signore
da conservare nella chiesa; il decreto precisa che se verrà trascurato
questo ultimo obbligo "nostram concessionem irritam decernimus
" (28).
Nella Visita Pastorale del 1728 troviamo la descrizione dell' altare
del Santissimo Nome di Dio o di Gesù Cristo: l'icona dell' altare
presentava il monogramma JHS adorato da due angeli, da S. Domenico,
S. Francesco, S. Giovanni Evangelista Imperatori, Regine e Pontefici
(29). I santi elencati sono quelli particolarmente
invocati dalla Confraternita.
Nella pergamena di casa Pergi tra le miniature abbiamo oltre San Domenico
e San Giovanni Evangelista anche il Battista e S. Elena imperatrice
che sorregge la croce; il ricordo di questi santi richiama il titolo
della chiesa sede della compagnia: San Giovanni e della Croce.
Possediamo quindi degli elementi che permettono di precisare subito
alcune questioni:
- la Confraternita fu fondata nel 1567 ed ebbe come titolo: Confraternita
del Santissimo Nome di Dio e di Gesù Cristo;
- nei documenti posteriori troviamo che però la denominazione
variava a seconda dell'estensore: Confraternita del Nome di Dio, o Confraternita
del Nome di Gesù o Compagnia di Gesù Cristo ( con altre
varianti);
- nel 1568 otteneva dal Vescovo di Sutri, Mons. Valenti, mediante rescritto
del vicario generale, Tullio Mancinelli, il possesso della chiesa di
San Giovanni e della Croce ( o delle due chiesuole fatiscenti con questo
titolo), l'Ospedale di San Giovanni con tutti ì beni annessi;
- nel 1569 i fratelli della Confraternita prendevano possesso della
Chiesa ( o delle chiese ) e dello Ospedale e cominciavano i lavori di
restauro e ricostruzione della chiesa di S. Giovanni e della Croce,
che, per decreto vescovile, manteneva questo titolo aggiungendo quello
del Santissimo Nome di Dio; nel 1578 la fabbrica non era stata ancora
ultimata;
- la Confraternita del Nome di Dio reggendo l'Ospedale di San Giovanni
di Tolfa riterrà sempre ufficialmente questa denominazione: CONFRATERNITA
DEL SS.MO NOME DI DIO E SUO OSPEDALE;
- nel 1582, in ossequio ai decreti di Pio V e Gregorio XIII, il padre
maestro Vincenzo de Cellis faceva istanza alla Curia Generale dell'Ordine
dei Predicatori affinché confermasse l'istituzione della Confraternita
tolfetana.
Bisogna puntualizzare che, secondo la tradizione, le Confraternite del
SS. mo Nome di Dio furono fondate nel 1274 allorché con una Bolla
spedita nel Concilio di Lione il 21 settembre di quell'anno da
Gregorio X al Beato Giovanni da Vercelli, Generale dei Predicatori,
il Pontefice approvava i sodalizi che promuovevano il culto del nome
di Dio e di Gesù Cristo.
La sede primaria dell' Arciconfraternita é sempre stata Santa
Maria sopra Minerva dell'Urbe (30 ).
II Vicario Generale dell'Ordine convalidava l'istituzione del sodalizio
già avvenuta alcuni anni prima conferendo alla Confraternita
di Tolfa tutti i benefici spirituali, oneri e diritti
provenienti dall'aggregazione e approvazione dell'Ordine Domenicano.
Cap. 3 STRUTTURA DELLA CONFRATERNITA
(Finalità-organizzazione interna-numero
dei soci regolamenti)Per ricostruire la struttura di una confraternita, le
sue finalità e impegni spirituali e caritativi sono di capitale
importanza gli " Statuti " locali e quelli dell'Arciconfraternita
primaria.
Purtroppo gli archivi locali e quelli delle Curie di Sutri e Civitavecchia
non hanno conservato gli " Statuti " del nostro sodalizio. La
ricostruzione, nei minimi dettagli, della struttura della Confraternita
tolfetana ci é risultata particolarmente ardua. Tuttavia, considerando
l'affinità con quella " sorella. " di Civitavecchia e
la ricca documentazione attinente la Confraternita ( decreti, decisioni,
verbali, regolamenti e cariche dei soci, libro mastro e registri di spesa)
é stato possibile ricostruire a grandi linee la struttura della
Compagnia laicale tolfetana.
Avendo come punto di riferimento iniziale i citati " Statuti "
, ricopiati a cura della Confraternita Civitavecchiese e contenenti norme
di carattere generale per tutte le Confraternite con quella denominazione
notiamo che nonostante che il rescritto di Pio V nell'anno VI del suo
Pontificato avesse, con suo Breve , dettato le norme che dovessero essere
eseguite dalle Confraternite del SS.mo Nome di Dio e
che soprattutto esse venissero fondate in tutti i Conventi dell'Ordine
dei Predicatori e che senza il permesso del Generale di detta Congregazione
non " possino essere istituite" (31 ), non ci risulta che a Tolfa fosse mai esistito né un convento
ma neanche una chiesa dove l'Ordine dei Domenicani officiasse la Messa.
Comunque al di là di queste considerazioni, a Tolfa come abbiamo
visto, fu possibile istituire detta Confraternita che in modo anomalo
aveva finalizzato il suo interesse non solo verso opere squisitamente
religiose e di culto, ma soprattutto nella gestione dell'Ospedale e della
Chiesa di San Giovanni, con una posteriore approvazione dell' Ordine Domenicano.
Da un'attenta analisi degli statuti della Confraternita del SS. mo Nome
di Dio che erano similari un po' in tutto il mondo cattolico, si può
rilevare che anche quella di Tolfa in molti aspetti si avvicinava alle
consorelle, ma differenziandosi sostanzialmente per gli interesse specifici
della stessa.
Infatti, la cura dell' Ospedale e gli altri impegni tipici del sodalizio
tolfetano, la uniscono alle altre omonime confraternite per la finalità
spirituale posta all' origine della pia aggregazione." Il fine per
cui fu eretta questa Confraternita fu quello di lodare e benedire l' ineffabile
SS. mo Nome di Dio e di Gesù Cristo, in opposizione al disprezzo
che con orrore de’ buoni e della natura stessa, l'ingratitudine
e malizia umana ne fa con spergiuri e bestemmie".
La Confraternita si atteneva alla regola di associare i cadaveri dei fratelli
e sorelle nella Chiesa da essa officiata cioé di San Giovanni,
e di prestargli tutti i suffragi previsti; inoltre predisponeva un sussidio
per le povere zitelle orfane.
Per quanto riguarda l'abito dei confratelli del SS.mo Nome di Dio, dobbiamo
rifarci alle consuetudini generali della Confraternita che prevedeva un
sacco bianco, la mozzetta " turchina ", un cingolo attorno alla
vita e sulla mozzetta l'emblema del sodalizio costituito dal monogramma
.IHS, sormontato dalla croce. Il monogramma del Nome di Gesù, diffuso
ovunque da San Bernardino da Siena, viene riportato su tutti i registri
e i libri della Confraternita, come pure su alcune case di Tolfa ( 32 ).
La vestizione dei confratelli avveniva in modo solenne nel rispetto delle
norme seguite anche dagli altri sodalizi laicali. Il rituale viene conservato
ancora nell'Archivio di S. Egidio, Civitavecchia 1982. Insieme ai tradizionali
" Offizio della B. V.M. e dei Morti " molto in uso presso tute
le confraternite, insieme a numerose altre pratiche di devozione raccolte
in libri e opuscoli ad uso dei confratelli e conservate negli stalli del
coro dove " si cantava l'Offizio ".
A tutto quello che era previsto dagli statuti generali per l'esercizio
dell'autorità e per i singoli uffici, la Confraternita di Tolfa,
aggiungeva tutti gli uffici inerenti all'attività ospedaliera privilegiata
all'atto di fondazione e la presenza dell'eremita del Santuario della
Rocca, a lei affidato nel 1567.
Possiamo anche definire il ruolo ricoperto in alcuni uffici e il numero
effettivo dei soci.
Il responsabile della Confraternita era il Priore che aveva come compito
l'amministrazione delle rendite della medesima rispondendo " dinanzi
a Dio ed alla stessa Confraternita quei danni e pregiudizi che per sua
colpa potessero derivare ".
Era quindi compito del Priore far verificare ogni tre mesi i conti delle
entrate e delle uscite, organizzare per la fine di ogni anno la elezione
dei nuovi organi statutari; invitare alle congregazioni il Vicario foraneo
della Diocesi, convocare la congregazione segreta e predisporre il bilancio
annuale della Confraternita stessa da sottoporre all'approvazione della
congregazione.
Insieme al Priore ogni anno veniva eletto il sotto Priore che coadiuvava
il Priore nelle sue incombenze a predisporre i provvedimenti necessari
per il buon andamento della Confraternita, inoltre aveva il compito di
apporre le sue firme dopo il Priore su tutti i mandati di pagamento.
Una funzione molto importante soprattutto per il buon andamento amministrativo
della Confraternita era quella affidata ai sindaci che in numero di due,
eletti anche loro annualmente, avevano il compito di verificare il conto
trimestrale che doveva essere esibito nelle congregazioni, stimolare ì
" cercatori " ( Confratelli che si dedicavano alla questua nei
giorni festivi ) e gli esattori e predisporre nei tempi previsti le rendicontazioni,
inoltre intervenivano alle varie congregazioni come tutti gli altri eletti.
Annualmente si eleggeva anche tra i sacerdoti presenti nel paese, il Cappellano
che aveva il compito di officiare la Messa nella chiesa di San Giovanni,
di prestare la sua opera spirituale sia ai Confratelli ma soprattutto
agli infermi dell'Ospedale.
Ogni anno tra i confratelli venivano eletti sia gli infermieri che avevano
il compito di prestare gratuitamente la loro opera nell'Ospedale che I'Ospitaliere
che aveva il compito gravoso della gestione dell'Ospedale e che viveva
all'interno dello stesso.
Essendo la Confraternita una organizzazione che viveva delle elemosine
dei cittadini un compito abbastanza gravoso e importante lo avevano i
" cercatori" anche loro eletti annualmente che dovevano essere
oltre che capaci di saper coinvolgere la gente ad offrire i beni necessari
per l'Ospedale, soprattutto onesti in quanto dovevano consegnare alla
Confraternita quanto avevano raccolto.
Attraverso un'indagine che passa dalle congregazioni di fine `500 fino
alle ultime della seconda metà dell' 800 , abbiamo potuto verificare
che coloro che facevano parte delle congregazioni non erano mai stati
più di ventiquattro ( 1771), ma spesso il loro numero era stato
più esiguo da dodici a sedici o diciotto.
Venivano eletti, come abbiamo già detto a scrutinio segreto nel
mese di dicembre di ogni anno attraverso il sistema delle palle bianche
(voto favorevole) e delle palle nere (voto contrario).
I verbali da noi presi in considerazione non ci hanno mai portato a conoscenza
in modo chiaro dove avvenissero le riunioni della Congregazione, ma possiamo
evincere, anche da quanto normalmente accadeva per le altre Confraternite
esistenti a Tolfa, e da quanto avveniva in tutto il resto del mondo cattolico,
che dette congregazioni si tenessero nell'oratorio della Chiesa di San
Giovanni.
Cap. 4 - L' ATTIVITA' OSPEDALIERA DELLA CONFRATERNITA
a ) -La gestione dell'Ospedale nei secoli XVI - XVII
- XVIIILa storia della Confraternita va di pari passo con quella
dell'Ospedale da lei gestito. Non possiamo quindi omettere uno sguardo
d'insieme alle vicende della benefica istituzione dalla presa di possesso
da parte del sodalizio fino al suo totale declino.
Alla finalità spiccatamente spirituale di rendere onore al Nome
SS.mo di Dio e di Gesù Cristo e di riparare le bestemmie, la nostra
Confraternita, come si é visto prese fin dal suo nascere un impegno
caritativo a servizio degli infermi dell'Ospedale tolfetano di San Giovanni.
Questo assorbì gran parte delle sue energie. e , pur tenendo conto
della gestione delle chiese di San Giovanni e della Rocca con i vari riti
ivi celebrati e delle altre opere di carità esercitate, la manutenzione,
la direzione e il buon funzionamento dell'Ospedale, hanno sempre rivestito
una primaria attenzione. Ciò si evince da tutti i verbali delle
congregazioni in nostro possesso e dai libri di amministrazione.
La dimensione comunitaria della vita del paese risalta soprattutto dalla
caratteristica istituzione di opere di interesse pubblico come la cura
dell'Ospedale e la costruzione delle Chiese. Esse non nascono mai per
un impulso di un privato ma sono sempre il prodotto di una volontà
comune.
Da qui il proliferare di confraternite e associazioni
con scopi sociali, come per esempio la Confraternita del SS. mo Nome di
Dio e il suo Ospedale, che avevano il compito di ricercare, seppellire
e curare coloro che erano morti o malati in campagna lontani dal paese
e che si reggeva su un volontariato (33).
L Ospedale di San Giovanni era ubicato nel!' attuale piazza Matteotti
e perdurò fino agli inizi del nostro secolo.
La Confraternita, fin dall'atto di fondazione, non si era solo assunto
il compito di onorare il Nome dì Dio e riparare le bestemmie, quanto
piuttosto quello spiccatamente caritativo. Lo si deduce anche dal fatto
che veniva identificata sempre come " la Compagnia dell'Ospedale
". E' questo anche il motivo che ci impone una trattazione più
lunga e accurata rispetto agli altri capitoli.
Del resto per la " correzione della bestemmia " a Tolfa, esisteva
già un altro sodalizio ( la Confraternita del SS.mo Salvatore)
il cui scopo primario includeva proprio la correzione del turpiloquio
e della bestemmia nei giorni festivi (34)
.
Lo stile usato nella cura degli infermi e nella direzione del personale
sanitario emerge in un verbale della Congregazione ( riunione ) dei "
confratri " (35 ) tenuto il 25 novembre
1636 ( cioè solo cinquanta anni dopo il riconoscimento ufficiale
della Confraternita ), nel quale possiamo leggere : " Avanti il molto
Rev. sig. Don Yacomo Zamponi vescovo foraneo della Tolfa é stata
radunata la Congregazione dei fratelli della Ven. Compagnia del Santissimo
Nome di Dio dalli sigg. Bonizi priore... " seguono i nomi del vice
Priore, del Camerlengo, del Segretario e di tutti i partecipanti.
Nel testo del resoconto della seduta leggiamo ancora
:"...s'intende che sarebbe cosa facile che i confratelli
che sogliono attendere al servizio degli infermi verrebbero
volentieri a servire questo nostro Hospitale sempre ché alli
medesimi fussero fatte condizioni di poterci stare et ponendo
che questo Hospitale habbia entrate assai sufficienti per
poterceli introdurre, e considerando che con simile occasione si
verrebbero ad argumentare il servizio di Dio a beneficio dei
poveri infermi... "
. Evidentemente l'assistenza nell'Ospedale avveniva in forma volontaristica,
ma esso era istituito e funzionante e godeva già di alcune rendite.
Dal contesto della delibera si rileva pure il pensiero del!' espositore,
il quale fa osservare che la sola abnegazione non basta a compensare gli
infermieri e quindi a chi più si impegna nella cura degli infermi
è necessario provvedere almeno riconoscendogli un compenso a rimborso
del tempo occupato in tale benefica opera.
La delibera prosegue con argomenti di ordinaria amministrazione fra cui
la decisione di eseguire alcuni lavori di riadattamento dello stesso ospedale.
Il concetto di compensare gli infermieri venne ribadito e precisato nella
" raddunata " del 1 gennaio 1639 nel verbale della quale, dopo
il solito preambolo e l'elenco dei partecipanti, leggiamo
"...nella medesima congregazione é stato anche resoluto di
fare il prato dell'Acqua Bianca a Menico spitaliero per scudi tre l'anno
che se le diano per esercimento di salario et sue fatiche che fa per l'hospitale"
( 36 ).
In conclusione, sulla base dei documenti citati e di altri verbali di
sedute, si può affermare che:
a) fino a quella data l'assistenza ai malati era prestata gratuitamente
dai confratelli;
b) almeno dal 1639 si riconosce un compenso a chi assisteva gli infermi,
anche se in forma ibrida concedendo ad essi un terreno a basso fitto.
b) - Situazione dei ricoveri (37 )
I primi anni dell'apertura dell'Ospedale e soprattutto
dopo l'affidamento dello stesso alla Confraternita del SS. mo Nome di
Dio, furono anni di rodaggio per la organizzazione del servizio, che sicuramente
non era molto efficiente, al di là della grande buona volontà
e predisposizione che potevano metterci i confratelli che vi prestavano
volontariamente il loro servizio, tanto è vero
che dalla registrazione degli infermi, che inizia nel 1611, troviamo 18
ricoverati, dei quali cinque morivano durante le fasi del ricovero e tre
dei cinque erano forestieri (38 ).
Il registro purtroppo è carente sia per quanto riguarda la causa
del ricovero, che i giorni di degenza e l'età dei ricoverati.
Nel 1616 i ricoverati sono già ben 37, dei quali otto però
morivano durante il ricovero, ma, un dato risalta subito agli occhi dalla
lettura del registro, ben 29 dei 37 ricoverati sono forestieri tra i quali
4 milanesi, 2 bresciani, 1 bergamasco, molti toscani e marchigiani ,segno
evidente che l'Ospedale era divenuto il punto di riferimento non solo
dei locali, che in realtà usufruivano molto poco della struttura,
ma soprattutto di forestieri che sicuramente in gran parte lavoravano,
o avevano rapporti , con le vicine cave di allume (39).
II 1621 è stato un anno sicuramente molto importante per lo sviluppo
dell'Ospedale, che venne messo a dura prova sia nelle sue strutture ricettive,
ma soprattutto per quanto riguarda la capacità di poter dare agli
utenti un servizio medico efficiente ed alla altezza della situazione,
Infatti con molta probabilità Tolfa fu soggetta
ad una epidemia in quanto troviamo ben 123 ricoveri con 32 morti, 69 dei
ricoverati erano forestieri provenienti dalle Marche, Toscana, Lombardia
ed altre regioni ( 40) .
La Confraternita per far fronte alle aumentate necessità e bisogni
della struttura ospedaliera era costretta in quegli anni ad aumentare
il numero dei posti letto presenti nel nosocomio, infatti troviamo tra
gli acquisti un consistente numero di pagliericci e materassi, coperte
di lana, camicioni per i malati.
Dal registro degli inventari delle proprietà dei beni della Compagnia
del SS. mo Nome di Dio nella Tolfa, con annesso inventario dei beni della
Chiesa di S. Giovanni e del!' Ospedale del SS. mo Nome di Dio nell’amministrazione
del Cap. ( Capitano o Cappellano ) Vinciguerra, del m° ( maestro o
mastro ) Andrea Framura e Mons. Cellio Celli Camerlengo, anno 1617, troviamo
tra i beni immobili alcune case, cantine e soprattutto appezzamenti di
terreno che venivano dati in affitto, spesso in cambio di una parte del
raccolto, che veniva sicuramente utilizzato all'interno dell'Ospedale;
inoltre detto inventario riporta i beni presenti nella Chiesa di S. Giovanni:
vi erano quattro candelieri in ottone, quattro lanternoni dorati per la
processione, confessionali, pianeta, stendardi etc. ; più interessante
invece l'inventario dei beni dell'Ospedale con materassi di lana e di
crine, pagliericci, coperte di lana, camicioni per malati, lenzuola, una
credenza, alcune mestole, una graticola ( evidentemente nell'Ospedale
c'era un camino con doppia funzione : sia per cucinare, che per riscaldare
gli ambienti ) , una tinozza per lavare gli ammalati (evidentemente si cercava di curare anche l'igiene degli infermi ), oltre
a materiale vario di carattere ospedaliero quale ferri per chirurghi,
pinze per estrarre i denti etc. (41 )
.
In un primo tempo le disposizioni della Curia di Sutri da cui la Confraternita
e l'Ospedale dipendono sono molto rigide, tanto è vero che l'inventario
deve essere annuale, poi vediamo che incomincia a subentrare un certo
lassismo e gli inventari vengono predisposti ogni cinque poi ogni sette
e addirittura nove anni.
In quello effettuato nel 1652 (42) troviamo
tra le altre cose una spada ed un paio di stivali, segno evidente del
passaggio di un soldato, forse morto durante la degenza, una cappa o un
mantello con relativo attaccacappe ed un marchio di ferro per marchiare
il bestiame, probabilmente lasciato da qualche allevatore o mercante che
si recava alla Tolfa per acquistare capi di bestiame.
Evidentemente la situazione della gestione e dei controlli sull'Amministrazione
dell'Ospedale lasciò per qualche tempo a desiderare, finché
nella deliberazione del 12 maggio 1675 venne discusso e approvato un Regolamento
unico e generale per tutte le confraternite, che nel frattempo andavano
moltiplicandosi, emanato dal Vescovo di Sutri e Nepi Card. Giulio Spinola,
per regolamentare la vita di queste iniziative, che con l'andare del tempo,
avrebbero potuto travisare i nobilissimi intenti per i quali e con i quali
erano nate.
E' interessante scorrere il regolamento per notare che "... non si
elegghino per Priori o altri Officiali padre e figlio, né zii e
nipoti e chi é stato eletto una volta, non si elegga di nuovo (...)
e però ogni 15 giorni prima sia finito il tempo dell'Officiali
vecchi, quelli che avevano retto la Confraternita nell'anno immediatamente
trascorso, il Consiglio della Compagnia si congreghi insieme e si faccia
elezione dei nuovi Scindicatori ( sindaci revisori dei conti) per voti
segreti, quali non siano parenti almeno in primo o secondo grado alli
Priori o Camerlenghi, e vedano fra questo tempo (15 giorni) i conti per
l'amministrazione dell'entrata e dell'uscita (... ) et ordiniamo che chi
sarà chiamato debitore dalli Scindicatori sborsi subito in mano
al nuovo Camerlengo quello che deve... " Ed ancora, all'art. 7 "...quando
si averanno da fare affitti , si facciano ad estinsione di candela, e
poste prima le solite cedole ( avvisi, bandi) (... ) si daranno a quelli
che più offeriranno ... "
Dopo altre regole, riguardanti l'amministrazione dei beni della Confraternita,
si passa ad una lunga esposizione dei doveri che hanno gli ospedalieri
in un contesto apposito, intitolato appunto " De gl'Hospitali ",
ove fra l'altro viene precisato : " Se bene intorno alla cura degl'Hospitali
(...) si sono dati buoni ordini, si stima bene di più avvertire
l'Hospitaliere che quelli che si ammettono devono essere ricoverati gratis,
senza ricevere cosa alcuna, ancorché spontaneamente offerta (...
), l'ospitaliere prima di ricevere forestieri deve informarsi da dove
vengono e non ricevere uomini con giovanetti o uomini con donne, se non
dopo accertato che siano padre e figlio o marito e moglie, non si ammettano
armati e nel dubbio si avvertano gli amministratori (...) le rendite destinate
all'Ospedale non si possono spendere in modo diverso,
anche se vi fosse residuo (di bilancio) (...) le donne saranno curate
dalle donne, gli uomini dagli uomini ... gli officiali (... ) guardino
se ( gli infermieri) sono puntuali nel somministrare ad essi ( malati)
tutto ciò che bisogna secondo l'ordine dei medici ... " (43 ).
Quanto sopra ci porta a concludere che la vita delle Confraternite e degli
Ospedali, fino a quel tempo limitata e governata in maniera empirica,
aveva avuto una notevole espansione tanto che, da parte delle autorità.
si era sentita la necessità di emanare qualche editto che ne regolasse
la vita amministrativa ed assistenziale.
Una notevole quantità di documenti ritrovati nell'Archivio del
Comune, dell'Ospedale e della Confraternita del SS.mo Nome di Dio, ci
portano a conoscenza dello stato di disagio della Comunità della
Tolfa di fronte al problema della salute pubblica nel XVIII secolo.
Infatti nei 1741 il Consiglio Comunale chiedeva che la condotta medica
venisse assegnata ad un altro chirurgo "perché un venturiero
angaria la cittadinanza chiedendo somme esorbitanti per le sue prestazioni
", nel 1770" trovandosi malato il dott. Pietro Pucilli medico
condotto ... sono stati obbligati chiamare il dott. Marsili
medico dell'Allumiere come vicinori a cui dovevano ogni mattina spedire
un cavallo perché venga una volta al giorno a visitare i malati
... " (44 ).
Nell'anno 1743 era scoppiata una grave epidemia e il Consiglio Comunale
nella seduta del 13 luglio dovette prendere le opportune decisioni per
evitare il contagio. " Con editto della Sagra Consulta sopra le precauzioni
di Sanità nell'emergente sospetto del mal contagioso ... ci viene
ordinato di chiudere questa terra con fratte e fastelli e guardie ai medesimi
con i soliti bollettini di sanità " .
Il cons. Buttaoni propone che " ... per venire in fare luogo alla
costruzione e fattura delle fratte attesa la scarsezza degli uomini che
abbiamo per esserne quaranta in circa applicati alla guardia della marina,
altro numero maggiore applicato al servizio del negozio e campagna delle
Lumiere et alli nuovi testi ossia cave di piombo et altri minerali e quasi
deltutto il popolo rimanente alla raccolta del grano, non possiamo dar
principio ai taglio delle fascine e trasporto delle medesime se non da
chi da domenica prossima a venire " . La comunità ordinò
a tutti gli uomini di campagna di fare ciascuno venti fascine " ben imbrigliate e di trasportarle con cavalli da basto e somari messi a disposizione
dai proprietari per servizio della comunità talmente che li padroni
delli medesimi possino attendere a tal servizio pubblico e supplire alle
altre loro faccende di campagna " (45 ).
Le misure precauzionali comunque furono sufficienti in quanto troviamo
ricoverati nell'Ospedale di Tolfa un numero di ammalati poco più
alto degli anni precedenti ed allo stesso modo i morti non subirono variazioni
eccessive ma si tennero nella norma.
Negli anni successivi l'Amministrazione dell'Ospedale lascia a desiderare,
infatti nel 1765 si rileva quanto segue : "Sussiste che l'Ospedale
di questa terra si ritrova in necessità estrema di dover per molte
necessarie spese di suppellettili mancanti per servizi degli infermi che
continuamente in esso si curano " .
Era infatti divenuto molto difficile sostenere dette spese in quanto dai
libri dell'Amministrazione si rileva in quell'anno un pesante disavanzo,
così anche nel 1780, anno in cui le entrate sono di scudi 303,98
e le uscite di scudi 488,06.
" ... In prova della totale sussistenza dell'esposto nel memoriale
del Venerabile Ospedale della Terra della Tolfa, unitamente alla informazione
di quel giudicante mi dò l'onore umiliare il foglio di quelli pubblici
rappresentanti con altri documenti dai quali non solo si rileva essere
eccedente il numero dei malati che quest'anno in esso ospedale sono stati
ricoverati e curati ma di essere ancora sussistente l'avversa rimessa
che per tal cagione ha dovuto quel luogo Pio soffrire..".
Nel 1780 troviamo poi lamentele avverso il medico chirurgo "... detti
professionisti e specialmente il medico chirurgo poco o quasi niente han
fatto contro, nella caduta influenza dei poveri che più di ogni
altro devono essere a cuore...."
L'affluenza degli infermi è stata in questa terra tanto nel!' anno
precedente che nel presente abbondantissima, infatti troviamo nel registro
degli infermi di quegli anni circa centocinquanta malati.
La situazione non era molto migliorata qualche anno più tardi se
troviamo una missiva del clero locale al Mons. Vescovo di Sutri, nella
quale si fa presente una situazione che è divenuta ogni anno più
difficile da gestire in quanto sono molti i malati ricoverati : "
Noi sottoscritti Rettore Parroco dell'insigne chiesa collegiata di S.
Egidio e coadiutore della Parrocchia, attestiamo che mediante la cresciuta
popolazione ascendente a circa tremila anime compresi i forestieri addetti
alla coltura dei capi ed alla custodia del molto bestiame specialmente
vaccino che forma il primo ramo di commercio di questa medesima terra,
attesa la lontananza degli stessi campi, le strade disastrose, le salite
montuose e l' aria divenuta alquanto insalubre dopo il
taglio seguito di molte selve territoriali, si ritrovano in tutte le stagioni
infermi da diversi mali infetti... e segnatamente ne era ripieno l'ospedale
ove il gran numero dei campagnoli non erano sufficienti i letti (46 )
Nonostante tutto la vita della Ven. Confraternita del Santissimo Nome
di Dio e quella dell'Ospedale da lei gestito continuarono in maniera più
o meno tranquilla finché non vennero bruscamente interrotte dalle
note vicende della Repubblica Romana del 1798 - 1799. Vediamone le conseguenze.
Il libro delle Congregazioni si ferma sotto la data del 5 febbraio 1798,
cioè appena dieci giorni prima che il generale Berthier proclamasse
in Roma l'avvento della Repubblica Romana.
In quella data si svolse una noiosissima assemblea, presieduta dal Rev.
Domenico Buttaoni in rappresentanza del Vescovo De Simoni, ove si discussero
cose di ordinaria amministrazione, quasi non ci si avvedesse della bufera
scatenata in tutta Europa dalla Rivoluzione Francese, come se questa non
potesse assolutamente sfiorare la pacifica comunità di Tolfa.
La Congregazione seguente fu tenuta solo il 29 dicembre 1799 a ben ventidue
mesi dalla precedente, il che dimostra la impossibilità dei confratelli
di riunirsi più spesso come era loro abitudine, almeno per l'elezione
annuale degli amministratori.
In quella data lo steso Mons. Buttaoni radunò la Congregazione,
alla quale parteciparono, cosa insolita soltanto tredici Confratelli,
e nella quale possiamo fra l'altro leggere : " ... il Sig. Can. Pasquini
eletto Camerlengo ( per l'anno 1800 ) considerando la molteplicità
delle incombenze particolarmente per la provvisione di tutto l'occorrente
tanto per la Chiesa che per l'Ospedale per la depredazione generale fatta
dai francesi, dice di non poter egli solo attendere a tutte le incombenze
del camerlengato, onde fa istanza che si elegga altro soggetto che lo
assista e lo aiuti particolarmente nella provvista delle cose occorrenti
" .
Si affiancò al Camerlengo il sig. Sante Zoppini . Più avanti
la stessa delibera così prosegue :" ... susseguentemente proposto
che atteso il guasto accaduto nella Chiesa servita per quartiere alle
truppe repubblicane dell'estinto governo ed anche la depredazione già
sopra accennata di tutti i mobili, suppellettili, biancheria e vasi sacri
é necessario di ristaurare et imbiancare la suddetta Chiesa e di
provvedere il calice tanto per la chiesa di questo Ospedale quanto per
la chiesa della Rocca, la pisside per il viatico, il vasetto per l'olio
santo, tovaglie e tutte le altre biancherie e suppellettili per il servizio
della chiesa e degli infermi.
Onde le ss.II. risolvino.
Insorse il sig. Bonizzi Filippo il quale era intenzionato di dare le opportune facoltà ai suddetti sig. Canonico Camerlengo
e Sante Zoppini di fare tutte le spese necessarie .e di restaurarsi, come
sopra, ottenendone il dovuto permesso dai legittimi superiori. Date le
palle e raccolte furono esse trovate tutte bianche " (47 ).
Le votazioni all'interno della Confraternita si tenevano su ogni singola
proposta e sempre a scrutinio segreto per mezzo di palle bianche, se favorevoli,
nere, se contrari.
Dopo le suddette votazioni la Congregazione venne chiusa con la solita
formula.
E' evidente che dopo qualche tempo tutto fu ripristinato e sia la Confraternita
che l'Ospedale ripresero le loro attività benefiche animate e sostenute
dalla estrema buona volontà dei Confratelli.
c)
La soccida delle vacche e la gestione dell'ospedale nel sec.XIX
Nel
1803 la Confraternita del SS. mo Nome di Dio intraprende una attività
completamente nuova, entra infatti in società con il Sig. Angelo
Buttaoni per anni cinque per gestire, nei pascoli sociali, delle vacche,
nasce così la Società delle Vacche che andrà avanti
fino al 1872. Dalla società la Confraternita ricaverà sempre
un buon utile e qualche volta anche carne fresca per i malati.
Si legge negli atti che in detta società sono a carico del Buttaoni
le gabelle o tasse, il movimento delle vacche da un pascolo all'altro,
la metà del ricavato dalla vendita dei vitelli, inoltre alla fine
dei cinque anni le vacche saranno divise in parti uguali e la Confraternita
è chiamata per prima a scegliere la sua parte.
L'investimento fatto in detta società è talmente produttivo
che nel 1808 al momento dello scioglimento della società con il
Buttaoni, la Confraternita si ritrova con il capitale più che raddoppiato,
infatti le otto vacche sono già divenute diciannove ed inoltre
va aggiunto quanto ricavato ogni anno dalla vendita dei vitelli.
Nella successiva società con il sig. Domenico Bartoli 1808 - 1813,
la Confraternita aveva ricavato un utile ancora più alto del precedente
che addirittura è triplicato in quella con i fratelli Giuseppe
e Francesco Mignanti, tutto ciò a beneficio dell'Ospedale che ne
incamera gli utili.
Nel 1828 all'inizio della nuova società la Confraternita ha un
capitale vaccino di ben ventidue vacche sode, tre seccaticce di anni due,
tre di un anno e quattro vitelloni di un anno.
Per quasi un altro mezzo secolo la Confraternita gestirà la Soccida
delle Vacche con molti altri allevatori ed ogni anno molti capi di detto
bestiame saranno trasferiti, come è consuetudine
per gli allevatori tolfetani, alla fiera della Quercia di Viterbo, che
si teneva nel mese di maggio, per essere ivi venduti, mentre alcuni vitelloni
e vacche saranno macellati successivamente per la disponibilità
di carne per l'Ospedale ( 48 ).
Negli anni che vanno dagli inizi del secolo XIX alla fine dello stesso,
la Confraternita e l'Ospedale passano attraverso una situazione che andrà
sempre più a modificarsi, soprattutto per le note vicende storiche
che caratterizzeranno il secolo, con lo scioglimento della Confraternita
ed il passaggio dei suoi beni e dello stesso Ospedale tra le ( Istituto
per Assistenza e Beneficienza) gestite direttamente dallo Stato e sottratte
alla giurisdizione ecclesiastica.
Nei 1809 vengono fatti lavori di manutenzione straordinaria del tetto
dell'Ospedale, una spesa abbastanza consistente, evidentemente la situazione
politica molto confusa sia in Italia che in Europa di quegli anni aveva
condizionato gli amministratori dal fare investimenti, inoltre tra le
spese troviamo una somma molto alta per l'acquisto di china ( o chinino)
, per far fronte ai malati di malaria, che in quegli anni colpiva molti
dei braccianti che lavoravano nelle campagne di Tolfa, soprattutto nelle
zone limitrofe al mare, presso le, quali veniva praticato l'allevamento
del bestiame, soprattutto pecore ( transumanza) .
Con la fine dell'attività lavorativa delle cave di allume, si erano
venute a modificare notevolmente non solo le attività lavorative,
ma anche la composizione stessa della presenza dei forestieri sul nostro
territorio, infatti agli uomini provenienti dal nord Italia e legati alle
attività minerarie, vengono a sostituirsi soprattutto umbri, marchigiani
e viterbesi legati invece alle attività agricole e dell'allevamento
del bestiame.
Se qualcuno fosse interessato ad una ricerca di carattere sociale ed antropologica
sulla composizione e provenienza di molti dei nostri avi, basterebbe che
si facesse un giro nei Comuni oppure nei cimiteri dei molti paesi dell'alto
maceratese : Vísso, Ussita, Amandola, Soriano, per trovare qui
molti dei cognomi che oggi sono presenti nell'anagrafe del nostro paese.
Comunque nel 1824 sono novantotto gli ammalati ricoverati nell'Ospedale
di "Piazza Vecchia" ( attuale piazza G. Matteotti ), tra i quali
ben sessantanove forestieri, due soltanto i morti dì quell'anno
che verranno sepolti nella Chiesa di S. Giovanni dopo aver ricevuto i
sacramenti.
Nonostante la creazione del cimitero, l'editto di S. Cloud di napoleonica
memoria è passato invano sui monti della Tolfa, visto che i morti
continuano ad essere sepolti in Chiesa.
Anche nel 1825 gli infermi ricoverati sono poco più di ottanta,
con solamente due morti, ma troviamo quattro malati provenienti da Rota;
otto sono quelli del 1830.
Evidentemente la tenuta di Rota, passata, alla fine del secolo XVIII,
nelle mani dei Lepri ( attuali proprietari ), scesi a Tolfa da Como per
fare gli appaltatori delle cave di allume e poi trasformatisi in proprietari
terrieri, era utilizzata in modo sempre più frequente da allevatori
di bestiame e da contadini, è probabile che i malati, dai dati
in nostro possesso non ne siamo potuti venire a conoscenza, avessero la
malaria, in quanto la zona, fino a non molti anni fa, era una di quelle
più a rischio dell'intero territorio tolfetano.

|